
Non è stato un uomo facile, Philip Milton Roth, figlio di Hermann e Bess, ebrei galiziani immigrati, americano fin dentro il midollo. Alto, ossuto, testone, indisponente, immerso dentro il pozzo profondo della sua umana esperienza : parole e parole e parole, ricordi e ricordi, incontri, sogni e incubi macinati e affilati negli anni fino ad estrarre la grana splendente del racconto.
: parole e parole e parole, ricordi e ricordi, incontri, sogni e incubi macinati e affilati negli anni fino ad estrarre la grana splendente del racconto.
Era il 1969, quando Lamento di Portnoy mise a soqquadro il mondo delle lettere americane, e non solo. Il libro, confessione tragicomica di un giovane ebreo irrequieto, parlava di sesso e masturbazione, di psicanalisi e di donne, di desiderio carnale, di malessere sociale e famigliare. La provocazione esplose come una fucilata anche nel 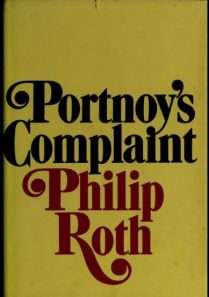 quieto e accomodato recinto dell’ebraismo americano. Uno scandalo, seguito dalla vergogna di famiglia, dall’anatema e dall’immediata espulsione dalla comunità, alla quale il giovanotto Philip rispose a suo modo: me ne frego.
quieto e accomodato recinto dell’ebraismo americano. Uno scandalo, seguito dalla vergogna di famiglia, dall’anatema e dall’immediata espulsione dalla comunità, alla quale il giovanotto Philip rispose a suo modo: me ne frego.
E tuttavia prima del capolavoro, c’era stato – ed era il 1959 – uno smilzo libro di racconti che già conteneva in origine tutto il mondo dello scrittore. Addio Columbus fu anche il mio testo di esordio con Philip Roth: una fulminazione. Ecco dunque la magia della vera letteratura: le parole di un giovane ebreo americano che parlano alla testa e al cuore di un adolescente italiano che niente sa di America, di ebraismo, di baseball, di ragazze con le lentiggini, la coda di cavallo e il diaframma nascosto nel cassetto della biancheria.
Dopo Addio Columbus, leggere tutti i libri e ogni nuovo libro di Philip Roth è stato un percorso di crescita individuale, un lungo rito di passaggio attraverso la narrazione. I suoi racconti ci hanno affascinato, indispettito, ci hanno fatto arrabbiare e innamorare. L’ebreo errante delle lettere americane ha creato nei decenni il suo personale Teatro del Sabbah, ha inventato una folla di alter ego teneri e indisponenti, ha raccontato la sua e la nostra America.
affascinato, indispettito, ci hanno fatto arrabbiare e innamorare. L’ebreo errante delle lettere americane ha creato nei decenni il suo personale Teatro del Sabbah, ha inventato una folla di alter ego teneri e indisponenti, ha raccontato la sua e la nostra America.
Ci voleva un dolente nichilista come Philip Roth per squarciare il velo dell’innocenza puerile di un popolo – decenni prima delle Torri gemelle – e proclamare il trionfo dell’innata rabbia cieca dell’America. Lo scrittore di Newark sceglie proprio queste parole per raccontare nella sua Pastorale americana quel funesto giorno del ringraziamento del 1973, che nel romanzo segna la fine delle illusioni, la rovina di una famiglia, la sconfitta di un uomo e della sua generazione.
 Scrittore civile, anche. A differenza di Saul Bellow e Bernard Malamud, Roth non ha mai lasciato il campo della polemica politica. Ha immaginato un’America soggiogata dal nazismo, ha affrontato con sarcasmo la psicosi anticomunista del suo grande e infantile Paese. Negli ultimi anni, sostenitore di Barak Obama, sferzante fustigatore di George Dabliu Bush, orripilato di fronte a Donald Trump: «Mentitore seriale, ignorante e fanfarone».
Scrittore civile, anche. A differenza di Saul Bellow e Bernard Malamud, Roth non ha mai lasciato il campo della polemica politica. Ha immaginato un’America soggiogata dal nazismo, ha affrontato con sarcasmo la psicosi anticomunista del suo grande e infantile Paese. Negli ultimi anni, sostenitore di Barak Obama, sferzante fustigatore di George Dabliu Bush, orripilato di fronte a Donald Trump: «Mentitore seriale, ignorante e fanfarone».
Non si può immaginare uno scrittore più americano di Philip Roth. Eppure, l’incontro a Torino con Primo Levi, nel settembre dell’86, somiglia a un ricongiungimento e a un reciproco riconoscersi. Dice Roth a Levi: «Tu sembri una persona la cui esigenza più profonda è quella di avere radici. Eppure, quando ti sei trovato più solo e sradicato di quanto si possa essere, hai considerato quella condizione un dono, un regalo». È una domanda, o piuttosto una confessione? Il celebrato scrittore americano, l’uomo del vasto mondo, riconosce sé stesso nell’esperienza del fratello ritrovato, il cui orizzonte è un angusto universo concentrazionario. Primo Levi come ennesimo alter ego di Philip Roth, o viceversa.
profonda è quella di avere radici. Eppure, quando ti sei trovato più solo e sradicato di quanto si possa essere, hai considerato quella condizione un dono, un regalo». È una domanda, o piuttosto una confessione? Il celebrato scrittore americano, l’uomo del vasto mondo, riconosce sé stesso nell’esperienza del fratello ritrovato, il cui orizzonte è un angusto universo concentrazionario. Primo Levi come ennesimo alter ego di Philip Roth, o viceversa.
C’è infine un Roth del tramonto, del crepuscolo. Negli ultimi anni, il suo insistere sul tema della malattia e della morte ci aveva irritato e deluso. Noi lettori lo avremmo voluto sempre vigoroso e sfacciato: un uomo nel pieno 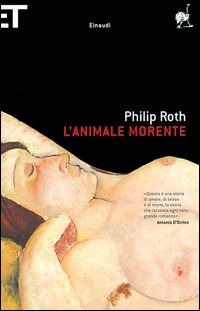 della sua forza e affondato nel turbine dei suoi desideri. Ora che il sipario è calato, possiamo invece riconoscere nella sua ultima fragilità, nella sua disperazione di animale morente l’identità mai tradita tra vita e opera letteraria.
della sua forza e affondato nel turbine dei suoi desideri. Ora che il sipario è calato, possiamo invece riconoscere nella sua ultima fragilità, nella sua disperazione di animale morente l’identità mai tradita tra vita e opera letteraria.
Per mezzo secolo Philip Roth ha raccontato sé stesso, e insieme tutti noi. In ogni suo libro ha ingaggiato un corpo a corpo disperato e ironico con le categorie più aspre e difficili dell’esperienza umana: la famiglia, la terra, il sesso, la malattia, la morte, l’amore in tutte le sue declinazioni. E ancora, il padre, la madre, la fratellanza, la religione o il deserto della religione. Ora che è morto, possiamo dirlo: il nostro campione non si è mai tirato indietro.
Per questo Philip, l’ebreo errante di Newark, New Jersey, è uno scrittore universale. Per questo la sua opera – tutta la sua sterminata opera letteraria – è stata un dono d’amore.



