
Questa è, se non l’ultima, una delle ultime interviste concesse da Primo Levi pochi mesi prima di togliersi la vita trent’anni fa esatti, l’11 aprile 1987. Fu pubblicata su “l’Unità” (inspiegabilmente di “taglio basso”!), nella pagina della cultura il 25 settembre 1986. A raccoglierla Andrea Liberatori, all’epoca caporedattore de “l’Unità” di Torino, giornale nel quale era entrato nel 1948, quand’era ancora studente di ingegneria al Politecnico, e nel quale ha lavorato per quarant’anni – per un lungo periodo, fra il 1957 e il 1962, anche a Milano – prima come segretario di redazione, poi cronista, inviato, caporedattore. Ha contribuito anche, con Giulio Trevisani e Arturo Lazzari, alla creazione dell’Enciclopedia nuovissima, uscita a dispense con il “Calendario del popolo” nel periodo in cui il giornale fondato da Antonio Gramsci fu diretto da Aldo Tortorella e Aniello Coppola svolgeva il ruolo di capo redattore. Per dodici anni Liberatori è stato anche nel consiglio dell’Ordine dei giornalisti del Piemonte.
Oggi Andrea Liberatori, un lucidissimo ed impeccabilmente cortese ultranovantenne, ha voluto ricordare l’amico Primo Levi – della cui morte toccò scrivere la cronaca – con uno scritto che fa da postfazione a Questo è un uomo, l'”appassionata” biografia che Daniele Pugliese, anch’egli a lungo a “l’Unità” grazie proprio a Liberatori ed oggi direttore di TESSERE, ha voluto dedicare a quello che considera il più clamoroso “mancato” Nobel per la letteratura della storia e, come scrive Massimo Giuliani nella prefazione del libro, «maestro e guida, divenuto suo malgrado un Virgilio dantesco per le generazioni del dopo-Auschwitz, di un “dopo” che, ahinoi, è sempre un “oggi” di guerra», “un” uomo del cui pensiero e della cui scrittura «abbiamo ancora bisogno, anzi abbiamo nostalgia».
L’intervista. Le polemiche oltreoceano e il prossimo impegno letterario
Primo Levi: La mia America
i miei anni in fabbrica
ANDREA LIBERATORI

«Sì, c’è un rapporto stretto fra Se questo è un uomo e I sommersi e i salvati. Tanto stretto che, forse ricorderai, nel libro di quarant’anni fa un capitolo è intitolato proprio I sommersi e i salvati. Anzi, io volevo che questo fosse il titolo dantesco del libro. Fu Franco Antonicelli, che lo pubblicò per l’editore De Silva (un lettore di Einaudi lo aveva rifiutato), a preferire Se questo è un uomo che io ho sempre trovato di gusto vittoriano».

Nella casa di corso Re Umberto, in un appartamento al terzo piano, Primo Levi parla di due suoi libri, il primo e l’ultimo («La critica di Raboni su “l’Unità” mi è parsa una delle più interessanti»). La stanza in cui parliamo fa parte di lui, della sua storia. Non solo perché vi lavora e qui, dunque, è nato lo scrittore ormai noto in tutto il mondo. «Sono proprio nato in questa camera, sono nato lì» e indica ridendo un punto del pavimento al di sopra del quale adesso c’è la macchina da scrivere che Levi alterna al “processore di parole” che trova molto pratico. «Non è più difficile da usare che guidare un’auto. Ed è molto meno pericoloso».
I saggi che compongono I sommersi e i salvati lo hanno impegnato quasi sei anni. Ma in questo stesso periodo ha scritto Se non ora, quando?, un libro ben accolto in Europa, che gli ha creato una strana situazione negli Stati Uniti.
«Il libro è stato una specie di scommessa con me stesso. Ho ritrovato in un cassetto gli appunti sul racconto che mi aveva fatto Emilio Vita Finzi e mi son detto: “Proviamo un po’ a scrivere un romanzo-romanzo piantandola lì con l’autobiografia mascherata o aperta».
Pensi di aver vinto la scommessa?

«Direi di sì, ero in uno stato d’animo felice, disposto all’invenzione. In Italia il libro è andato bene, in Germania va anche bene così e in Inghilterra. Negli Stati Uniti no. E c’è un motivo esplicito. Se non ora, quando? è un libro sull’ebraismo ashkenazita che in Italia è pochissimo conosciuto e soltanto attraverso altri libri di scrittori americani oppure di vecchi scrittori yiddish. Insomma è noto ad una piccola élite. Io, lo dico senza falsa modestia, volevo sfruttare la mia popolarità per far conoscere in Italia questo ebraismo orientale, quello russo e polacco con tutti i suoi modi di dire, i suoi priverbi».
Primo Levi ha finto di tradurre un testo dall’yiddish. Un normale artificio letterario.
«Ma negli Stati Uniti l’yiddish lo sanno. Singer, Philip Roth, Saul Bellow, Salinger sono tutti scrittori di origine yiddish». Roth è stato a Torino in questi giorni ospite di Levi. La visita ha qualcosa a che fare con la traduzione negli Usa di Se non ora, quando?
«No, ha a che fare con La chiave a stella che sta uscendo in questi giorni negli Stati Uniti. Roth è venuto per parlarmi e scrivere un articolo sul supplemento letterario del “New York Times”».
A chi non è piaciuto in America Se non ora, quando?
«Là si sono accorti che questa mia cultura hiddish era di seconda mano, non era, come dire?, nativa. Quella élite ebraico-americana ha una posizione dominante sulla scena letteraria. E anche nello spettacolo, anche nei film. Ha un pubblico vastissimo, pensa solo agli spettatori che ha Woody Allen. Quei film non li vedono mica solo gli ebrei. Perciò questa cultura di radici russo-polacche è conosciuta. Così è bastato che alcuni critici ben noti abbiano lodato il libro, ma a denti un po’ stretti e facendo alcune riserve, per influenzare molto le vendite».
 Ma hai ricevuto anche degli attacchi personali?
Ma hai ricevuto anche degli attacchi personali?
«Una rivista ebraica, di destra, dell’estrema destra reaganiana, ha stroncato il libro senza mezzi termini. Ha detto questo è un falso libro. Mi hanno accusato anche di una cosa vera, di esser un ebreo assimilato. E io lo sono, sono anche ben fiero di esserlo. Oltretutto non è neppure una scelta. In Italia si vive così. Nessuno mi dice “ebreo” per la strada. In quel curioso articolo l’autrice fa addirittura carico, non a me ma alla cultura ebraica italiana, di aver fornito due primi ministri, Sonnino e Luzzatti. Come a dire questi ebrei italiani son talmente assimilati che fanno addirittura i primi ministri… Le ho risposto ricordando che ad ogni ebreo nel mondo – ma direi ad ogni uomo – viene imposta una certa collocazione sociale. Non è che io abbia scelto la mia situazione di ebreo integrato nella cultura italiana. Ci son nato, ho seguito le scuole italiane, la mia unica lingua è l’italiano, non posseggo una seconda lingua come gli ebrei russi e polacchi. Poi ho aggiunto: ma lei, signora, scrive in inglese, non in ebraico. Quindi anche lei è assimilata. Ha scelto un livello di assimilazione diverso dal mio».

Pare che in generale però i tuoi libri abbiano buona accoglienza anche negli Stati Uniti.
«Sì, specialmente dalla fine dell’84 in poi. Quell’anno, sotto Natale, qualcuno chiese a Saul Bellow, che aveva appena ricevuto il Nobel, quale fosse per lui il libro dell’anno. Lui indicò il mio Sistema periodico. Due righe sui giornali che sono state la mia fortuna».
In Vizio di forma, nel 1971, c’è una sorta di apologo. Scrivi dei lemming, i roditori che travolgono lo scienziato per andare verso la morte. Gli arsenali atomici, quindici anni dopo, sono ancora più minacciosi, se possibile. La condizione umana è cambiata?
«Sono un ottimista e non credo alle catastrofi, anche per ragioni di sopravvivenza. Se ci credi smetti di vivere. Ho scritto quel racconto in un momento di depressione».

Ottimismo e speranza?
«Senza speranza, credo, non si può vivere. Non ho una filosofia precisa; come tutti oscillo. A seconda di quello che si vede in Tv il mio ottimismo viene anche scosso. Nella vita politica nostra mi pare ci sia stata una degradazione. Una mutua degradazione. Ci si influenza a vicenda, fatalmente. Fra dominante e dominato c’è uno scambio fatale per cui il livello morale della classe dominante influenza il livello morale dei soggetti, dei cittadini. E viceversa. È uno dei temi dei Sommersi e salvati».
Chimico, per decenni direttore di stabilimento, Levi ha molto viaggiato. Ma il suo osservatorio privilegiato è questo torinese.
«Anche Roth pensa qualcosa del genere. Dopo avermi mandato le sue domande con una lettera è venuto qui con la sua compagna, una persona deliziosa, Claire Bloom, sì la ballerina di Luci della ribalta. Lui mi ha detto: “Vorrei vedere Torino coi tuoi occhi”».
C’è riuscito?
«L’ho accompagnato nel centro storico ed ha definito la città cordiale e un po’ logora».
Primo Levi, autore fra i più fedeli della casa editrice, come segue la crisi dell’Einaudi?
«Col fiato sospeso, sono anche un creditore importante. Ma a parte questo sono amico di tutti là dentro. Certo se dovesse andar via da Torino dovrei ripensare molte cose. Mi pare però sia interesse di tutti che l’Einaudi rimanga, in ogni senso, l’Einaudi. Qualunque acquirente, che non sia del tutto sprovveduto, si renderà conto di questo».
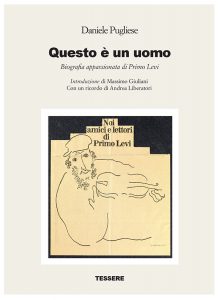 Mentre auspica la più rapida e felice soluzione della crisi Einaudi, Levi sta scrivendo qualcosa?
Mentre auspica la più rapida e felice soluzione della crisi Einaudi, Levi sta scrivendo qualcosa?
«Avevo cominciato un libro prima che lo stato di salute di mia madre me ne distogliesse. In questo momento non ci sono le condizioni per scrivere».
Di che si tratta?
«È un altro sistema periodico, organico invece che inorganico. Ho in mente di sfruttare il capitale di successi, insuccessi, grane, entusiasmi, disperazioni del mio trentennio in fabbrica».
“l’Unità”, 25 settembre 1986




