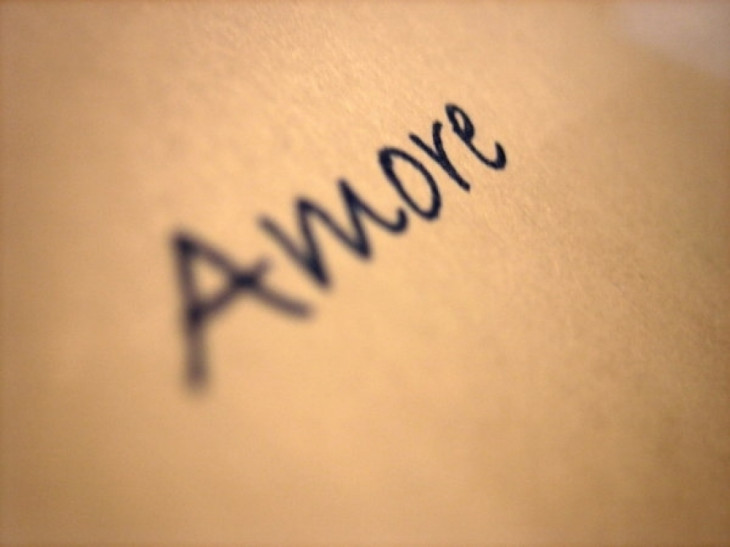
La letteratura come bussola per orientarsi in quel complicato-semplicissimo spazio che è l’amore. Con o senza la A maiuscola. A fornire questo prezioso strumento di orientamento, Maria Serena Palieri, giornalista che ha lavorato per trent’anni a “l’Unità”, occupandosi per lo più di libri, cultura e donne e che, come saggista ha pubblicato Amorosi assassini(Laterza, 2008), Donne del Risorgimento(2011), Donne nella Grande Guerra(2014), Donne della Repubblica(2016) e Donne nel Sessantotto(2018) con il Mulino e Radio Cairo. L’avventurosa vita di Fausta Cialente in Egitto(Donzelli, 2018). Per Iacobelli editore è appena uscito Amore è una parola, viaggio tra le pagine che vanno dalla Nora di Ibsen, alle donne spezzate di de Beauvoir e Ferrante, dalle inossidabili “coppie” israeliane agli amori gay d’Occidente, da eroi ed eroine del “rosa” agli amanti perseguitati dall’integralismo. Per gentile concessione pubblichiamo il primo capitolo.

Il 1923 è l’anno in cui Karen Blixen trentottenne, reduce da un disastro di coniugio con il cugino Bror che, insieme con il cognome che userà da scrittrice, le aveva lasciato la sifilide, scrive Il matrimonio moderno, pamphlet uscito postumo quasi un cinquantennio dopo.
In quel 1923 l’autrice delle Sette storie gotiche, la madre di Ehrengard e Babette, vive – così annota – in un mondo in cui «il fragore dei matrimoni che crollano rintrona la nostra generazione» (Blixen 1989). E ancora, nel 1923, uno sposalizio reggeva qualche anno prima di venire giù, non tre mesi come può succedere ai nostri giorni, quando lo wedding plannerprogramma tutto salvo la durata dell’unione… Karen Christentze Dinesen, però, era già consapevole di trovarsi all’estremo di un millenario esperimento umano che così, nel pamphlet, riassumeva nelle sue due fasi:
Dopo aver tentato per qualche tempo di edificare l’amore sul matrimonio, e dopo aver dato per scontato che dove c’era un matrimonio solido e ben riuscito l’amore sarebbe venuto spontaneamente a coronarlo… abbiamo rinunciato a questo metodo di costruzione, che tradiva qualche errore di calcolo, e abbiamo messo sottosopra l’intero edificio, ponendo alle fondamenta l’amore e prevedendo che su un sentimento forte avrebbe potuto sorgere facilmente un matrimonio solido e ben riuscito. (Blixen 1986, p. 47)
Il problema, dice Blixen, è che all’essere umano puoi chiedere tutto, sacrificarsi per una fede, per un’idea, per una terra, per un sovrano, e l’essere umano lo farà finché la sua tetragona tenuta non sarà corrosa dall’interrogativo: «A cosa serve?». È questo il tarlo che aveva minato la sua unione con Bror von Blixen-Finecke, primo lui a dubitare e a inanellare altre relazioni, poi lei: si separarono nel 1921 e divorziarono nel 1925.
Karen Christentze Dinesen è stata forse la prima a formulare in modo limpido la domanda. Ma certo non è stata la sola né l’ultima. Anzi. Quel «a cosa serve?» è diventato in Occidente un potente detonatore. Fino ad arrivare all’attuale estremo economicista così dipinto da Zygmunt Bauman: «Una relazione, ti dirà l’esperto, è un investimento come tutti gli altri: ci metti tempo, denaro, fatica che avresti potuto riservare ad altri scopi» (Bauman 2004). Come è successo? Cercando i motivi di questa deriva, quanto all’oggi, si parla in modo per lo più neutro di “individualismo” così come, secondo la formula dello stesso Bauman, di “società liquida”. Andando a ritroso, però, non è possibile non vedere il ruolo che nel corso del Novecento ha giocato la liberazione delle donne. Per ciò che concerne il sisma nei ruoli all’interno della coppia provocato dall’emancipazione (se lei lavora), dalla conquista dell’autodeterminazione (decido io su me stessa, in primis su sessualità e fecondità) così come dalla legittimazione dell’eros femminile. Certo, oggi una donna può chiedersi con tante più ragioni: «Un marito? A cosa serve?».
Nel mondo duplex della pagina scritta, però, si aprono, ben visibili per chi abbia occhio, anche altri scenari. Meno scontati, meno esplorati. Il primo è quello aperto da quel caposaldo concettuale che è Casa di bambola. Nora Helmer, la “lodoletta” che si sottrae alla dimensione pre-umana cui il marito Torvald la confina con questo appellativo e, a fine dramma, abbandona lui e i tre figli, è una sorta di Atena uscita dalla testa di un padre Zeus, Henrik Ibsen. Perché nel 1879 Ibsen, individuo di sesso maschile, in Casa di bambolasa prevedere e riassumere per intero la sfida con cui nel Novecento si cimenterà il pensiero femminile. Ed è, questa, una sfida etica.
È un testo addirittura proverbiale ma, prima di cominciare il nostro viaggio nella contemporaneità, vale davvero la pena di rivederlo passo passo nei dettagli. Nora, il “lucherino”, lo “scoiattolino” è, appunto, relegata tra le pareti domestiche, un grazioso animaletto in gabbia. Torvald, avvocato, ha appena ricevuto la nomina a direttore della Banca di Credito. E ora viene fuori che Nora ha contratto un debito con Krogstadt, dipendente della banca e in procinto di esserne cacciato. Milleduecento talleri, la cifra spesa per trascorrere con il marito e i bambini un anno in Italia, in un clima che i medici consideravano l’unica possibilità di salvezza per Torvald, all’epoca a rischio di vita. Soggetta all’autorità maritale, Nora per ottenere quel denaro ha falsificato la firma del proprio padre e quindi Krogstadt adesso la ricatta, chiedendole di influire sul marito e salvargli il posto di lavoro. Quando Torvald viene a saperlo decide che Nora non ha più i requisiti per essere moglie e madre, neppure in quel ruolo larvale cui era confinata e che da qui in poi si tratterà solo di fingere col mondo e di «salvare i resti, i relitti, le apparenze» (Ibsen 1972, p. 81).
Succede, però, che Kristine Linde, antica amica di Nora, rimasta vedova torni in città e bussi alla porta di casa Helmer, in cerca di aiuto. E così reincontra Krogstadt, suo vero amore di gioventù, lasciato per un matrimonio di convenienza necessario per provvedere economicamente a sua mamma e a due fratellini. Kristine, donna autonoma, può e sa giudicare l’uomo. Per lei non è solo un vile ricattatore. Avendo sperimentato quanto valga l’autenticità di un sentimento, poi, è disposta ora, nonostante tutto, a tornare con lui. Krogstadt, pacificato, rinuncia alla sua vendetta con gli Helmer. Torvald, dopo averlo saputo, decide anche lui di fare come se nulla fosse accaduto con Nora: la sua reputazione è salva, questo è quanto importa. Ma è qui che Nora Helmer si erge con una statura di donna ormai novecentesca.
Di quanto è successo in quei tre terribili giorni, in cui ha pensato al suicidio, questo ha ritenuto: «vengo a sapere che le leggi non sono quelle che io credevo» e «secondo tali leggi una donna non avrebbe il diritto di risparmiare un dolore al suo vecchio padre morente, e neppure di salvare la vita a suo marito». Perciò ritiene di dovere cercare il proprio criterio morale dentro se stessa. Abbandonerà i figli. Quanto al marito, la possibilità che lei e Torvald tornino insieme è nella categoria del «prodigio» perché dovrebbe succedere che cambino entrambi al punto che «la convivenza diventi matrimonio» (Ibsen 1972, pp.87 e seg.).
Benedetto Croce aveva intuito perfettamente la portata del dramma se, ancora nel 1950, cercava di scrollarne il peso. Certo, a modo suo.
Chi ha ragione in Casa di bambola? – scriveva. – Il marito? Ma è un egoista. La moglie? Ma non ha senso morale. Chi ha torto? Il marito? Ma è rispettoso della legge e dell’onore. La moglie? Ma ha voluto salvare il marito dalla malattia e dalla morte… E non è maraviglia che questi problemi insolubili dessero popolarità a quei drammi, e che vi s’interessassero particolarmente i poco critici cervelli femminili, e i meno critici tra essi, quelli delle femministe, e presto li rendessero, col loro psicologico e moralizzante o amoralizzante discettare, uggiosi e odiosi a segno che alcune famiglie scandinave s’indussero (l’aneddoto è noto), nell’inviare inviti per le loro serate, ad aggiungere a pié del cartoncino la raccomandazione: «Si prega di non discutere di Casa di bambola». (Croce in Panebianco, Gineprimi, Seminara 2012)
A Oslo il dilemma di Casa di bambolasarà stato lasciato, nelle case borghesi scintillanti di luci, nell’oscurità di un guardaroba con cappotti e soprascarpe da neve. Ma è un fatto che esso poi ha prodotto frutti in tutto il Ventesimo secolo. Non solo per il motivo più ovvio: la scelta di Nora che, stufa di sentirsi chiamare lodoletta e desiderosa di diventare adulta, abbandona Torvald. Ma per un dilemma più complesso, insieme nuovissimo e antico quanto Antigone: se Nora ha, a suo tempo, effettuato una scelta che lei ha avvertito come “giusta” dando alla vita dello sposo un valore più alto della norma che le impediva di contrarre un debito a proprio nome, qui non solo abbiamo una donna che ha scavalcato l’autorità del padre e del marito. Qui si è palesata un’etica “femminile” – siamo d’accordo con l’aggettivo, don Benedetto – nuova, che vuole dire la sua sul mondo. Quanto a Kristine, lei è già la nuova donna, perché andata sposa per provvedere ad altri, ora vedova, autonoma, proprio da questa esperienza di vita – il matrimonio di convenienza – e da questa conquistata indipendenza trae il diritto di contraddire il giudizio sociale, unendosi alla “feccia” Krogstadt.
Stando al nostro tema dell’amore e del matrimonio, poi, notiamo un altro passaggio. Né Nora né Kristine esercitano il loro giudizio morale sulla relazione sentimentale con l’uomo: non sono state né tradite né sedotte né abbandonate. Non è questo il punto. Entrambe, di più e semplicemente, dicono la loro a 360 gradi sul mondo e le sue leggi. Compiono una rivoluzione copernicana. È da questo mondo di cui ora si sentono cittadine, che decidono su di sé e sulla loro relazione con un marito, Torvald, e un amante, Krogstadt.
Questo è il cammino lungo, impervio, contraddittorio che impegnerà le donne nel Novecento. E che qui Ibsen con potenza profetica abbozza in un paio d’ore di rappresentazione.
Casa di bambolatermina con «il tonfo della porta che si chiude» alle spalle di Nora. La ex signora Helmer si avventura in un mondo che ancora ossequia l’idea che le donne siano “meno morali” degli uomini (motivo per cui a esse è interdetto il ruolo nella vita pubblica). È lei che, lasciati dietro di sé scialle multicolore e tamburello con cui diventava la danzatrice di tarantella dalla sensualità disciplinata che Torvald amava vedere una volta l’anno (né di più né di meno…), si reincarna 103 anni dopo nei viali di Harvard in Carol Gilligan? Gilligan, la psicologa dalla lunga chioma da vecchia hippie e dai tratti decisi, autrice di In a Different Voice, il saggio che nel 1982 sancisce la nascita di un autonomo «soggetto morale femminile»[1].
È, questo della soggettività etica femminile, un cammino contraddittorio e appunto mai finito. Simone de Beauvoir, come vedremo tra poco, per esempio assume su di sé in quanto autrice il giudizio morale sui suoi personaggi. Impaniate tutt’e tre, le donne dei tre racconti della raccolta Una donna spezzata, in una sorta di familismo amorale: concedono a se stesse ogni indulgenza in nome del legame con marito e figli, d’un ruolo esercitato o già perduto. L’occhio di de Beauvoir, su di loro, è implacabile.
Mentre ha una potenza grande il “no” che Olga, il personaggio di Elena Ferrante ne I giorni dell’abbandono, tira fuori da sé in un contesto per nulla epocale. Otto, il cane, è morto dopo aver mangiato un boccone in cortile o sulla strada lì fuori e a Mario, il marito che le chiede come sia successo, lei risponde così: «“Avvelenato” gli dissi e lui chiese con rabbia: “Chi è stato?”. “Tu” gli risposi tranquillamente. “Io?”. “Sì. Ho scoperto che sei un uomo sgarbato. La gente risponde agli sgarbi con la malvagità”» (Ferrante 2002, p. 203). Il giudizio con cui Olga – figura che gode di quella singolare intensità che Elena Ferrante conferisce ai suoi personaggi femminili – mette la pietra tombale sul rapporto con Mario non ha a che fare con la sua relazione con la giovane Carla, già babysitter dei loro figli. Non è un giudizio che si esercita sotto le coperte né tra le pareti domestiche. Si avventura e si esercita nel “fuori”: un fuori, anche se vicinissimo, quella società che già è presente nel cortile del condominio e nella strada su cui affaccia il palazzo.
È questa nuova irriducibilità femminile all’amoralità che alloggia dentro una famiglia o dentro una coppia uno dei congegni che, nella nostra società, viene da dedurre, nel Novecento hanno fatto saltare in aria molte specie di “amore”.
Ma in Nora Helmer, e dopo di lei in alcune donne di carta e alcune scrittrici in carne e ossa, si annida poi un’ipotesi ulteriore e molto più disturbante. Nell’andarsene da casa, Nora non nega – così possiamo ben immaginare – il suo sentimento verso i figli. Ne nega però la conseguenza e li abbandona. Badate che il suo gesto è tutto diverso da quello di Anna Karenina: questa, al contrario di Nora, vorrebbe tenere con sé suo figlio Serëža quando va a vivere con Vronskij, ma è Aleksei Aleksandrovič, suo marito, a impedirle anche solo di vederlo. Più giovane di soli due anni, la danese – venuta alla luce, lei, nel 1879 – della russa – venuta alla luce, quella, nel 1877 – è, sotto questo aspetto, già proiettata in un’inquieta landa novecentesca.
Virginia Woolf ne Le tre ghinee, ricostruendo la quotidiana prigionia, lunga una vita intera, delle fanciulle borghesi nell’età vittoriana (le «figlie degli uomini colti» secondo la peculiare definizione che lei usa), ritrova le tracce di una Mary Kingsley, a proposito della quale scrive:
E poi c’era il desiderio di non amare, di condurre un’esistenza razionale senza amore. «Devo umilmente confessare… che personalmente non so cosa sia l’amore» scrisse una di quelle figlie. Strana confessione da parte di una figlia della classe la cui unica professione per tanti secoli era consistita nel matrimonio. Altre volevano viaggiare; esplorare l’Africa; fare scavi in Grecia e in Palestina… (Woolf 2010, p. 181)
Lei, questa fanciulla di nome Mary, vuole anzitutto esplorare questa inaudita dimensione: non amare.
Il “non amare” si declina in più varianti e chiama in causa marito o figli o ambedue. C’è il sottrarsi all’obbligo di provare un sentimento, o comunque di agire come se lo si provasse, all’interno di un contesto socialmente dato: e qui siamo con Karenina che abbandona Aleksei per Vronskij come con tutte le mogli (ma anche tutti i mariti) che nella narrativa del Novecento trovano una nuova vita sulle macerie di un primo matrimonio.
C’è poi, sempre dentro quel contesto, cioè l’istituzione familiare, il sottrarsi non al sentimento ma a ciò che ne consegue: appunto ciò che fa Nora coi suoi figli. E con lei, nella vita vera, Doris Lessing che compie l’azione «più giusta e più orribile che ho fatto in vita mia» – così si giudica a posteriori nell’autobiografia – partendo per l’Inghilterra e lasciando in Africa il primo marito e i primi due figli, John e Jean, bambini. Con l’immaginaria Nora e con la vera Doris, l’altrettanto vera Louise Nevelson, grande artista, che riassume la propria intermittenza con questa formula: «Puoi essere una moglie ma non devi esserlo sempre. Puoi essere una madre ma non devi esserlo sempre». Così recitava uno dei suoi commenti alle sue stesse opere nei pannelli della mostra a lei dedicata nel 2013 dal Museo Fondazione di Roma.
C’è, poi, il sottrarsi al sentimento in sé, perché visto come una prigionia millenaria. E qui è l’amore romantico che viene rifiutato. È il “non amare” perché dentro il cuore non avviene, semplicemente. Ecco la fanciulla di cui scrive Virginia Woolf. Ma ecco anche quel personaggio di uno dei racconti di Alice Munro, Festa di fine estate, Valerie, a proposito della quale l’amica Roberta pensa: «l’amore è un sentimento del quale farebbe volentieri a meno». E ancora:
Il suo modo di vivere, la sua persona, più ancora di qualunque opinione possa esprimere, ricordano all’interlocutore come l’amore non sia buono né onesto e come non contribuisca alla felicità della gente in modo affidabile. (Munro 2008, p. 172).
Qui siamo di fronte alla negazione più drastica della «ultima riga delle favole» che ha propiziato i sogni di centinaia di generazioni di bambine e bambini. Ma il fatto è che quando a lavorare sono delle novecentesche regine della scrittura c’è da aspettarsi di tutto: che abbiano costruito il loro opusin segno inesorabilmente antiromantico, per esempio, come nel caso, ancora, di Doris Lessing, ma anche di Magda Szabó. Le narrazioni di Szabó e di Lessing non sono prive di cuore, tutt’altro. Ma il cuore e la passione trovano oggetti diversi dall’Amato, l’Amata.
Ne La porta, il capolavoro dell’autrice ungherese, una cameriera, Emerenc, ama d’una passione materna e totale la padrona che serve. Ne L’altra Eszteruna bambina povera e brutta investe di un odio appassionato la compagna dal nome d’angelo, buona, bellissima e ricca. Ne La ballata di Izala passione s’annida nell’amore che un uomo, Antal, nutre per i propri suoceri, Vince ed Etelka Szöcs.
I personaggi dell’universo narrativo lessinghiano, da parte loro, inseguono spesso sogni e sono soggetti di passioni, ma vagheggiano cose diverse dall’amore romantico o dalla gloria o dalla santità: proprio come il padre della scrittrice, Alfred Tayler, che sognava semplicemente filari rigogliosi e fruttiferi di piante in una terra impossibile. D’altronde, lei stessa spiegava che il dolore più cocente della sua vita l’aveva provato per l’addio a un gatto che aveva dovuto lasciarsi dietro le spalle da bambina, abbandonando la Persia.
Cosa ci mostrano queste scrittrici? La varietà di oggetti di interesse, oggetti d’amore, che dal Novecento a oggi il mondo va manifestando a chi sa spogliarsi – come loro hanno saputo fare – di quella sorta di categorie kantiane: gli imperativi romantici. Se preferite, gli occhiali rosa…
[1]Nel ricostruirne il succo, così riassumeva qualche anno dopo la filosofa Claudia Mancina: «Si distinguerebbe una moralità praticata dalle donne, che “pone al centro dello sviluppo morale la comprensione della responsabilità e dei rapporti”, da una moralità come equità, che “lega lo sviluppo morale alla comprensione dei diritti e delle norme”». Non siamo esattamente di fronte al conflitto Nora-Torvald?




