
Il vecchio ragazzo è tornato. Dall’alto dei suoi 87 anni compiuti, John le Carré riprende a correre sul campo delle spie. Il vegliardo ci sorprende con un romanzo (Agent running in the field, in Italia La spia corre sul campo, Mondadori) in cui le sottigliezze dell’intreccio virano in un sottobosco irridente e nostalgico. Si parla di spie, ovviamente, ma con uno stile sempre all’altezza dei tempi. E i tempi – che tu li scruti dal Ponte di Londra o dalla Torre Spasskaya di Mosca – sono davvero bui: «L’intera nazione è al collasso. La prima cosa che noti ogni volta che torni a casa è che non funziona niente, è tutto raffazzonato. La stessa sensazione che avevamo a Mosca ai tempi della guerra fredda».
Londra come Mosca, dunque. E in questa Londra gaglioffa e crepuscolare, tra fratelli coltelli e antichi rivali, si muove l’anti-eroe della vicenda: Nat, veterano cinquantenne del Secret Intelligent Service, «spigliato sotto pressione, buona aggressività latente», armato contro il suo mondo agonizzante di una massiccia dose di disincanto e insieme protetto dall’usbergo di un imperativo categorico squisitamente britannico.
Il romanzo appartiene al terzo tempo dell’anziano scrittore. In principio fu l’epoca fiammeggiante della guerra fredda: una storia di ferro e di fuoco, con il nemico dietro il muro e il tarlo del tradimento a insidiare le armate del bene. Occidente contro Oriente, e – in questo grande affresco epocale – amori, nostalgie, fedeltà dissipate, invidie menzogne e crudeltà. Per l’agente George Smiley le buie strade di Londra non erano allora meno pericolose dei corridoi della Lubianka.
Il secondo tempo arrivò in un piovoso autunno dell’89. «Ho letto i miei necrologi», commentò Sir John quando tutti, dopo il crollo del Muro, gli predicevano un avvenire da pensionato. Eppure, no: per un sublime creatore di trame il vasto pianeta aveva ancora mille occasioni, e lo scrittore si gettò nel gorgo dei nuovi complotti planetari: l’artiglio delle multinazionali, lo sfruttamento economico di interi continenti, infine lo scontro di civiltà. Crociati contro musulmani, le armate della fede in guerra contro la dissipazione occidentale di costumi e moralità.
Un mondo era esploso in mille pezzi e nel grande magma infuocato galleggiavano i resti di antiche fedeltà, lo sfasciume di imperi una volta potenti, il frastuono di una sordida guerra tra topi e batraci. Verso l’amata e rimpianta Old England, John le Carré condivideva la pena dell’antico maestro Thomas Stearns Eliot: «Sotto la nebbia bruna di un’alba di inverno/una gran folla fluiva sopra il London Bridge, così tanta/che io non avrei mai creduto/ che morte tanta n’avesse disfatta…».
Non piace a tutti, questa nuova versione dell’anziano scrittore. Apprendo dalla lettura di un dotto e compiacente articolo del “Foglio” che in patria John le Carré è stato accusato – e forse è ancora sotto giudizio morale – di intelligenza con il nemico. Nick Cohen, un giornalista della destra scapigliata, lo definisce «agit-prop moralista» e gli rimprovera il peccato di codardia. Secondo un altro censore, le Carré «si è reinventato come maestro dell’indignazione leftish», mentre James Parker gli rimprovera «il vizio più deplorevole degli intellettuali occidentali: la convinzione che l’occidente sia l’unico nemico che valga la pena di combattere».
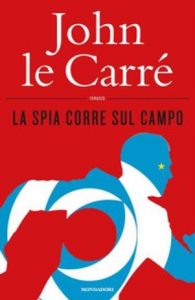 Accuse nemmeno velate di tradimento, verso le quali l’antico agente dei servizi segreti britannici risponde con le parole del suo ultimo protagonista: «Ho vissuto nella menzogna, ma nella menzogna necessaria, ho servito l’Inghilterra come la madre di tutte le democrazie, ho ammirato la nostra regina con inspiegabile ardore. Potrebbe essere un’Inghilterra che per noi non esiste più, ammesso che sia mai esistita…».
Accuse nemmeno velate di tradimento, verso le quali l’antico agente dei servizi segreti britannici risponde con le parole del suo ultimo protagonista: «Ho vissuto nella menzogna, ma nella menzogna necessaria, ho servito l’Inghilterra come la madre di tutte le democrazie, ho ammirato la nostra regina con inspiegabile ardore. Potrebbe essere un’Inghilterra che per noi non esiste più, ammesso che sia mai esistita…».
Siamo arrivati così al terzo tempo di John le Carré. Il nuovo paesaggio letterario è una fitta nebbia in cui non si distingue il torto dalla ragione, sono eserciti in rotta, un’atmosfera crepuscolare in cui anche lo spiare, il tramare, è una attività espletata con malavoglia e fastidio. L’Occidente è esploso, l’illusione islamista è affogata in un mare di sangue, Mosca è il solito enigma, l’Europa è un campo in cui tutti tramano contro tutti. E l’Inghilterra, infine: «Siamo un branco di post imperialisti nostalgici, che non saprebbero gestire nemmeno un banco di frutta al mercato». Questo – forse – per i critici di casa. Ma, come Graham Greene prima di lui, sono cinquanta anni che Sir John intona il controcanto della nostra storia, e nelle sue parole ad ogni passo riconosciamo la nostra minuscola vicenda umana. Il grande narratore scrive per noi, per sé e per la sua coscienza, e in questa spia che corre sul campo è l’atmosfera a dare il passo e il fascino alla scrittura, anche se il plot nelle ultime pagine zoppica e un po’ si perde.
Qui ognuno è reduce di qualcosa o qualcuno: il protagonista è reduce dall’illusione democratica, Il russo Arkady è reduce da un doppio tradimento e da un amore senza speranza, l’inesorabile Valentina è reduce dai sogni imperiali dell’Unione Sovietica, perfino l’inflessibile Renate («una valchiria tedesca in miniatura») è orfana dei giorni del Muro e di una antica e mai confessata storia di amore clandestino. Tutti, alla resa dei conti, saranno assolti, perché lo stigma dell’ultimo libro di Sir le Carré è infine la compassione. Merce rara in una classica storia di spie, e proprio per questo ancora più preziosa.
L’articolo è uscito su Succedeoggi, la factory gemella di Tessere





