
«Tu sei al mondo perché c’è posto!»
 L’avranno letta anche loro. Quando, dopo la morte, gli eredi di Salvatore Satta (Nuoro 1902 – Roma 1975) rinvennero tra le sue carte il manoscritto de Il giorno del giudizionon potranno non avere notato quella frase.
L’avranno letta anche loro. Quando, dopo la morte, gli eredi di Salvatore Satta (Nuoro 1902 – Roma 1975) rinvennero tra le sue carte il manoscritto de Il giorno del giudizionon potranno non avere notato quella frase.
Si deve alla famiglia se questo romanzo, dalle forti tinte autobiografiche, vide inizialmente la luce nel 1977 presso un editore specializzato in pubblicazioni giuridiche, per poi essere nuovamente dato alle stampe per i tipi di Adelphi nel 1979, divenendo ben presto un caso letterario di dimensioni mondiali.
Eppure il loro congiunto – autore di De profundis(1948) amara riflessione sulla guerra, Soliloqui e colloqui di un giurista(1968), docente di diritto in molte università italiane (Padova, Genova, Trieste, Roma La Sapienza) – mette questa frase lapidaria sulla bocca di Don Sebastiano Sanna, personaggio principale del romanzo.
Non sarà un caso se il giurista Salvatore Satta abbia voluto lasciare una sorta di testamento inedito con Il giorno del giudizioin cui il protagonista si chiama Sebastiano, esattamente come il padre dello scrittore, che esercita la medesima professione di notaio in Nuoro e il cui ultimo figlio si chiama proprio Salvatore.
 In quel microcosmo che era la società nuorese tra la fine dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale, la famiglia dei Sanna era giunta a quella condizione di benessere grazie alla professione del capofamiglia che sulla carta bollata aveva costruito la propria fortuna. E, consapevole di una specie di diritto derivante dalla posizione acquisita, liquida così in modo perentorio e sbrigativo coloro che non sono in sintonia col suo modo di pensare, compresa sua moglie Donna Vincenza: «Tu sei al mondo perché c’è posto!»
In quel microcosmo che era la società nuorese tra la fine dell’Ottocento e la seconda guerra mondiale, la famiglia dei Sanna era giunta a quella condizione di benessere grazie alla professione del capofamiglia che sulla carta bollata aveva costruito la propria fortuna. E, consapevole di una specie di diritto derivante dalla posizione acquisita, liquida così in modo perentorio e sbrigativo coloro che non sono in sintonia col suo modo di pensare, compresa sua moglie Donna Vincenza: «Tu sei al mondo perché c’è posto!»
Basandosi su questa sorta di assioma, lo scrittore passa al vaglio la società nuorese incardinata nell’arcaica fissità di princìpi immutabili, sulle cui vite aleggia un destino che il dio laico della classe di appartenenza ha in qualche modo già scritto. Il posto che ciascuno occupa in quel mondo rurale, è quello che per secoli ha scandito le vite di chi è transitato su quella terra, tra un atto di nascita e uno di morte, in un «sereno e assolutamente inconsapevole ateismo».
Anche Don Sebastiano, pur con tutti i suoi studi, non è immune da questo atteggiamento fatalistico e forse ancora di più Donna Vincenza che si muove nel suo piccolo mondo oltre il quale non c’è nulla o è indifferente se vi sia qualcosa, consapevole del fatto che in Sardegna la donna non esiste: è l’oggetto di un culto silenzioso, esposto alle vicende e strumento delle esigenze della vita, del marito e della famiglia; una presenza rarefatta, esterna a quello che è il dominio dell’uomo, cioè al governo del piccolo stato familiare.
Ciò avalla il fatto che Don Sebastiano dia tutto al lavoro esercitando il diritto di essere amato, ma al tempo stesso di non avere tempo per amare, finendo per rendere insanabile la frattura con Donna Vincenza. Così Don Sebastiano continuerà ad arrovellarsi tra i suoi crucci e le sue certezze derivanti dall’inchiostro vergato sulla carta bollata, e dalle terre e tanche che lui ha accumulato, come se rappresentassero esse stesse un giudizio del tempo speso in questa esistenza.
Del resto questo alone di precarietà accomuna un po’ tutti, in una teoria interminabile di personaggi che reca con sé la propria storia: gente sparita dalla memoria, o dissolta nel nulla, e che invece si ripete senza saperlo nelle generazioni, in una specie di eternità in cui non si comprende se sia il trionfo della vita o della morte.
Questa analisi non risparmia nessuno: lo Ziu Poddanzu, fattore delle terre di Don Sebastiano; gli sfaccendati del caffè Tettamanzi; il farmacista mangiapreti Boelle; il beone e bestemmiatore maestro Manca; il religiosissimo e disilluso maestro Mossa. E ancora un florilegio di tantissimi altri protagonisti, pastori, contadini, emigranti, faccendieri, ecclesiastici, avvocati, arricchiti o impoveriti, ignoranti o colti, religiosi o atei, le cui storie vengono offerte al lettore con affetto, nella ricerca di una possibile verità, e tutti accomunati dallo stesso destino che li ha veduti calpestare quella remota provincia.
Nuoro: in un paese che dormiva un sonno secolare, dove ciascuno viveva la sua apparenza di vita in case chiuse come fortilizi oppure alla farmacia o al caffè, solo nel cimitero, annerito dalla muffa del tempo, molteplici generazioni di nuoresi trovano un’effimera pace. Lo scrittore li accarezza, li ama, nel tentativo di redimerli e salvarli, consapevole che ciò che è finito è l’unica manifestazione dell’infinito.
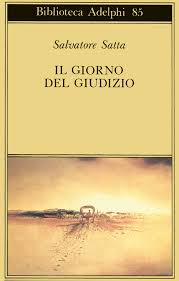 «Oggi, poi, di là dai vetri di questa stanza remota dove io mi sono rifugiato, nevica: una neve leggera che si posa sulle vie e sugli alberi come il tempo sopra di noi. Fra breve tutto sarà uguale. Nel cimitero di Nuoro non si distinguerà il vecchio dal nuovo: “essi” avranno una effimera pace sotto il manto bianco. Sono stato una volta piccolo anch’io, e il ricordo mi assale di quando sentivo il turbinare dei fiocchi col naso schiacciato contro la finestra. C’erano tutti allora, nella stanza ravvivata dal caminetto, ed eravamo felici poiché non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta dell’altrui destino ma del mio.»
«Oggi, poi, di là dai vetri di questa stanza remota dove io mi sono rifugiato, nevica: una neve leggera che si posa sulle vie e sugli alberi come il tempo sopra di noi. Fra breve tutto sarà uguale. Nel cimitero di Nuoro non si distinguerà il vecchio dal nuovo: “essi” avranno una effimera pace sotto il manto bianco. Sono stato una volta piccolo anch’io, e il ricordo mi assale di quando sentivo il turbinare dei fiocchi col naso schiacciato contro la finestra. C’erano tutti allora, nella stanza ravvivata dal caminetto, ed eravamo felici poiché non ci conoscevamo. Per conoscersi bisogna svolgere la propria vita fino in fondo, fino al momento in cui si cala nella fossa. E anche allora bisogna che ci sia uno che ti raccolga, ti risusciti, ti racconti a te stesso e agli altri come in un giudizio finale. È quello che ho fatto io in questi anni, che vorrei non aver fatto e continuerò a fare perché ormai non si tratta dell’altrui destino ma del mio.»




