
La prima cosa che viene in mente a chi scrive, e forse a chi legge, dovendo o volendo definire la parola di oggi, perché si è preso l’impegno di farlo, è, ovviamente, lo straordinario romanzo – perché di questo si tratta, benché a lungo lo si sia voluto confinare nel “ghetto” della sola memorialistica a cui pur appartiene – scritto da Primo Levi per narrare l’“odisseaco” viaggio di ritorno dal Lager a casa, dove ad attenderlo c’era l’incubo di cari che non stessero ad ascoltarlo, indisposti a credergli e pronti, un’altra volta, a girarsi dall’altra parte.
 La Tregua infatti s’intitola il secondo libro dato alle stampe dallo scrittore torinese nel 1963, sedici anni dopo l’uscita pressoché “in sordina” di Se questo è un uomo, ed è un libro che – come ha ben descritto qui in TESSERE Luigi Chicca nell’articolo Ecco cosa senti quando scopri “La Tregua” – non lascia indifferenti, come del resto la pressoché totale produzione libraria di Primo Levi, e se lo fa, invece, meriterebbe un attimo di riflessione, nel silenzio della propria stanza o allo specchio dinanzi al quale al mattino ci si lavano i denti, perché l’essere indifferenti è un malanno, di cui certamente chi ne soffre manco si rende idea, proprio perché è indifferente, ma è una mala pianta, perché appunto finisce per portare al Lager, anche se oggi è solo un sorriso beota o lo sguardo abbassato a chi ti parla guardandoti negli occhi.
La Tregua infatti s’intitola il secondo libro dato alle stampe dallo scrittore torinese nel 1963, sedici anni dopo l’uscita pressoché “in sordina” di Se questo è un uomo, ed è un libro che – come ha ben descritto qui in TESSERE Luigi Chicca nell’articolo Ecco cosa senti quando scopri “La Tregua” – non lascia indifferenti, come del resto la pressoché totale produzione libraria di Primo Levi, e se lo fa, invece, meriterebbe un attimo di riflessione, nel silenzio della propria stanza o allo specchio dinanzi al quale al mattino ci si lavano i denti, perché l’essere indifferenti è un malanno, di cui certamente chi ne soffre manco si rende idea, proprio perché è indifferente, ma è una mala pianta, perché appunto finisce per portare al Lager, anche se oggi è solo un sorriso beota o lo sguardo abbassato a chi ti parla guardandoti negli occhi.
 È, La Tregua, il libro di questo scrittore che, dopo la sua morte, mi sono lasciato per ultimo da leggere, rinviando e rinviando, rifiutandomi quasi di farlo, dandomi una tregua, per poter aver l’opportunità, all’occorrenza, di aver ancora qualcosa di suo da leggere, per potersi salvare anziché sommergere. Un libro “picaresco” così è stato definito dalla critica sottolineandone anche i tratti umoristici, ma d’una gravità che non lascia spazio alle facili consolazioni.
È, La Tregua, il libro di questo scrittore che, dopo la sua morte, mi sono lasciato per ultimo da leggere, rinviando e rinviando, rifiutandomi quasi di farlo, dandomi una tregua, per poter aver l’opportunità, all’occorrenza, di aver ancora qualcosa di suo da leggere, per potersi salvare anziché sommergere. Un libro “picaresco” così è stato definito dalla critica sottolineandone anche i tratti umoristici, ma d’una gravità che non lascia spazio alle facili consolazioni.
Nella prefazione all’edizione scolastica del romanzo uscita da Einaudi nel 1965, tentando di chiarire il senso della poesia posta in epigrafe al libro e di giustificarne il titolo, riferendosi al sogno ricorrente di cui narra nell’ultima pagina, Levi scrive:
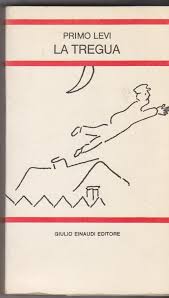 «Nel sogno, il Lager si dilata ad un significato universale, è divenuto il simbolo della condizione umana stessa e si identifica con la morte, a cui nessuno si sottrae. Esistono remissioni, “tregue”, come nella vita del campo l’inquieto riposo notturno; e la stessa vita umana è una tregua, una proroga; ma sono intervalli brevi, e presto interrotti dal “comando dell’alba”, temuto ma non inatteso, dalla voce straniera (“Wstawać” significa “Alzarsi”, in polacco) che pure tutti intendono e obbediscono. Questa voce comanda, anzi invita alla morte, ed è sommessa perché la morte è iscritta nella vita, è implicita nel destino umano, inevitabile, irresistibile; allo stesso modo nessuno avrebbe potuto pensare di opporsi al comando del risveglio, nelle gelide albe di Auschwitz».
«Nel sogno, il Lager si dilata ad un significato universale, è divenuto il simbolo della condizione umana stessa e si identifica con la morte, a cui nessuno si sottrae. Esistono remissioni, “tregue”, come nella vita del campo l’inquieto riposo notturno; e la stessa vita umana è una tregua, una proroga; ma sono intervalli brevi, e presto interrotti dal “comando dell’alba”, temuto ma non inatteso, dalla voce straniera (“Wstawać” significa “Alzarsi”, in polacco) che pure tutti intendono e obbediscono. Questa voce comanda, anzi invita alla morte, ed è sommessa perché la morte è iscritta nella vita, è implicita nel destino umano, inevitabile, irresistibile; allo stesso modo nessuno avrebbe potuto pensare di opporsi al comando del risveglio, nelle gelide albe di Auschwitz».
Eccoci qui, dunque, a dir qualcosa della tregua che vada al di là di quell’immenso spazio che Levi ci ha consentito di scandagliare.
 La trégua è – a detta del vocabolario Treccani – parola di origine germanica che deriva dal latino medievale treuga, sostantivo femminile che indica la «sospensione temporanea delle ostilità stabilita da due belligeranti ed estesa a tutto il teatro di guerra o a un solo settore, stipulata per raccogliere feriti, seppellire morti, prendere misure igieniche, chiedere ordini e istruzioni per agevolare trattative, ecc.».
La trégua è – a detta del vocabolario Treccani – parola di origine germanica che deriva dal latino medievale treuga, sostantivo femminile che indica la «sospensione temporanea delle ostilità stabilita da due belligeranti ed estesa a tutto il teatro di guerra o a un solo settore, stipulata per raccogliere feriti, seppellire morti, prendere misure igieniche, chiedere ordini e istruzioni per agevolare trattative, ecc.».
Altro non è, insomma, che una pausa fra due momenti della stessa guerra, quello che viene prima e quello che verrà dopo. È perciò un momento, un attimo, un “ora” e si potrebbe aggiungere – parola di cui, nella sua forma verbale, ci siamo già occupati – un divertimento, sottolineando quanto di gioioso ed addirittura gaudente – denso di felicità – possa esservi in quell’interstizio, in quella parentesi, in quello svago.
La sua derivazione, come purtroppo molte altre nel vocabolario, dal gergo militare e dallo stato di guerra, quantunque più non v’appartengano, dovrebbe inquietarci ed indurci a coniare neologismi che quel sapore diradino per far sì che il nostro linguaggio sia più pacifico e, con esso, la nostra esistenza, a cominciare dal rifiuto della soppressione e della violenza che, appunto, minano l’esistenza.
E, ce lo insegna sempre Levi, che da qualche parte ha scritto che la violenza inizia sempre con una violenza sul linguaggio.
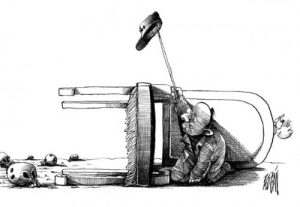 Presa nei suoi significati più generici, la parola continua ad alludere a questo stato di «sospensione temporanea», conseguente o meno a un patto, di ostilità, divergenze, contrasti e dissapori.
Presa nei suoi significati più generici, la parola continua ad alludere a questo stato di «sospensione temporanea», conseguente o meno a un patto, di ostilità, divergenze, contrasti e dissapori.
La stessa “polemica” a cui con una tregua si può dare interruzione, viene dal greco πόλεμος, la guerra, e sottende «un atteggiamento di sospetto e diffidenza contro un possibile attacco avversario». E allora eccola “salariale” nel sindacalese, “doganale” nel lessico dell’economia, e “di Dio” in quello religioso: istituto medievale messo a punto nel Concilio Lateranense del 1179, con cui, la rappresaglia veniva, a frequente intermittenza, bandita per obbedienza alle prescrizioni della Chiesa, per esempio dal Natale all’Epifania.
Ma qui si vuol richiamare l’attenzione su questa parola quando è impiegata per dar conto di una pausa, di una sosta, di un riposo, riferiti «a condizioni e situazioni dolorose, penose, spiacevoli»: dalle sofferenze che non danno tregua ai seccatori che perseguitano senza tregua; dalla pioggia, così definita come per i seccatori quando è incessante e prolungata o al lavoro fatto instancabilmente e “a marce forzate” per giungere al termine di esso. Anche alla fatica, pur spesa per passione.
Fortunatamente i poeti ne hanno fatto un uso anche, per così dire edulcorato, dando tregua ai sospiri (Poliziano), ai pensieri (Tasso), ancora alle ostilità ma per dar il senso del compromesso raggiunto, del patto finalmente stipulato: «Non far tregua coi vili», scrive il Manzoni, e c’è da supporre che essi non fossero dissimili dagli indifferenti.
Ma sia consentita una tregua anche alla riflessione. Un’ultima cosa, però: malgrado l’illustrazione, non si intenda la bandiera bianca come simbolo di tregua: essa indica anche il cessate il fuoco per riaprire le trattative – il prevalere della politica sugli armamenti – ma è anche simbolo di resa.




