

Un giorno, nell’autunno del 1979, Nilde Iotti appena eletta presidente della Camera, andò a Venezia per un convegno. Era solita ritagliarsi un attimo nel privato, e quella volta l’occasione fu la visita ad un museo. Nessun preavviso, entrò come una comune cittadina. Ad un tratto si accorse della sua presenza un gruppo di suorine che, festose, le vennero incontro, la salutarono, l’abbracciarono persino. Un compagno della “vigilanza” (la scorta di partito) storse la bocca. Nilde se ne accorse, ma fece finta di nulla. Più tardi, a tavola, ne volle riparlare con quel compagno. Ascoltò le sue riserve, quindi ribatté sorridendo: «Ma sono donne anche loro!»
Mi torna in mente questo piccolo episodio oggi, alla vigilia di quel 1° febbraio del 1945, quando il primo governo costituito dopo la Liberazione (presidente Ivanoe Bonomi), alle viste delle prime libere elezioni amministrative nelle zone del Nord dove era stato appena spazzato via il nazifascismo e cacciati i podestà.
 Bene, con uno dei suoi primi atti quel governo sancì per decreto che «il diritto di voto è esteso alle donne». Diritto di eleggere e di essere elette. Un momento grande ma dimenticato: certo, l’elettorato attivo e passivo a tutte le italiane fu conquistato con il referendum monarchia-repubblica dell’anno successivo e con le contemporanee elezioni per l’Assemblea costituente, ma resta il fatto che l’evento del 1° febbraio ’45 contrassegnò il primo momento della liberazione anche politica delle donne.
Bene, con uno dei suoi primi atti quel governo sancì per decreto che «il diritto di voto è esteso alle donne». Diritto di eleggere e di essere elette. Un momento grande ma dimenticato: certo, l’elettorato attivo e passivo a tutte le italiane fu conquistato con il referendum monarchia-repubblica dell’anno successivo e con le contemporanee elezioni per l’Assemblea costituente, ma resta il fatto che l’evento del 1° febbraio ’45 contrassegnò il primo momento della liberazione anche politica delle donne.
 Oggi sembra ovvio che le donne abbiano diritto di votare e di essere elette. E alle nuove generazioni parrà scontato che questo diritto risalga alla notte dei tempi. Invece non è così. Vero è che l’Italia non è la Svizzera dove il diritto elettorale attivo e passivo è stato “concesso” alle donne appena ieri, negli anni Settanta del ‘900, quando in Italia il diritto di votare ed essere eletti venne invece esteso ai diciottenni, ai giovani. Ma è vero anche che da noi c’è voluto quasi un secolo di battaglie politiche e sociali perché questo elementare diritto di democrazia si affermasse. E, appunto, fu una legge varata alla vigilia del 2 giugno ad affermare solennemente che sono elettori attivi e passivi, alle politiche come alle amministrative, «tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni». E quanta emozione, quel 2 giugno ’46, tra le donne – le anziane, le giovani, le nostre madri, le nostre nonne – nell’andare ai seggi con la consapevolezza di affermare così di esser davvero “cittadine”. Un atto storico.
Oggi sembra ovvio che le donne abbiano diritto di votare e di essere elette. E alle nuove generazioni parrà scontato che questo diritto risalga alla notte dei tempi. Invece non è così. Vero è che l’Italia non è la Svizzera dove il diritto elettorale attivo e passivo è stato “concesso” alle donne appena ieri, negli anni Settanta del ‘900, quando in Italia il diritto di votare ed essere eletti venne invece esteso ai diciottenni, ai giovani. Ma è vero anche che da noi c’è voluto quasi un secolo di battaglie politiche e sociali perché questo elementare diritto di democrazia si affermasse. E, appunto, fu una legge varata alla vigilia del 2 giugno ad affermare solennemente che sono elettori attivi e passivi, alle politiche come alle amministrative, «tutti i cittadini e cittadine italiani maggiorenni». E quanta emozione, quel 2 giugno ’46, tra le donne – le anziane, le giovani, le nostre madri, le nostre nonne – nell’andare ai seggi con la consapevolezza di affermare così di esser davvero “cittadine”. Un atto storico.
 Ma la storia, nel passato, aveva persino camminato all’indietro: la legge del 1866 per l’unificazione della legislazione della nuova Italia aveva infatti paradossalmente privato del diritto di voto (pur solo amministrativo) le donne della Toscana e del Lombardo Veneto che lo avevano sino ad allora esercitato grazie ad una qualche lungimiranza di granduchi e governatori. Poi una lunga serie di bocciature e di insabbiamento di progetti anche limitatamente favorevoli alle donne. Nel 1871, per esempio, il presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Giovanni Lanza (Destra storica), propone che le donne «potranno mandare il loro voto per iscritto» – insomma, che per carità non si presentino ai seggi –, ma solo per le amministrative. Perché la limitazione? «Qualche fondamento può esservi nelle costumanze per negar loro il voto politico». E comunque il progetto decade alla chiusura della sessione. Dieci anni dopo sarà un esponente della Sinistra, Agostino Depretis, a riproporre la necessità che le donne votino ma – ci risiamo – solo alle amministrative. La commissione della Camera modifica il progetto, lo circoscrive ancora (niente voto per posta, semmai «per delega» al marito!) ma mette in dubbio che «l’innovazione sia avvalorata dal consenso e dall’autorità di tutti i partiti»: «Niuno di noi impugna il diritto naturale della donna al suffragio; e solo si discute intorno alla convenienza e opportunità di applicarlo». Risultato, anche questo progetto si arena.
Ma la storia, nel passato, aveva persino camminato all’indietro: la legge del 1866 per l’unificazione della legislazione della nuova Italia aveva infatti paradossalmente privato del diritto di voto (pur solo amministrativo) le donne della Toscana e del Lombardo Veneto che lo avevano sino ad allora esercitato grazie ad una qualche lungimiranza di granduchi e governatori. Poi una lunga serie di bocciature e di insabbiamento di progetti anche limitatamente favorevoli alle donne. Nel 1871, per esempio, il presidente del Consiglio e ministro dell’Interno Giovanni Lanza (Destra storica), propone che le donne «potranno mandare il loro voto per iscritto» – insomma, che per carità non si presentino ai seggi –, ma solo per le amministrative. Perché la limitazione? «Qualche fondamento può esservi nelle costumanze per negar loro il voto politico». E comunque il progetto decade alla chiusura della sessione. Dieci anni dopo sarà un esponente della Sinistra, Agostino Depretis, a riproporre la necessità che le donne votino ma – ci risiamo – solo alle amministrative. La commissione della Camera modifica il progetto, lo circoscrive ancora (niente voto per posta, semmai «per delega» al marito!) ma mette in dubbio che «l’innovazione sia avvalorata dal consenso e dall’autorità di tutti i partiti»: «Niuno di noi impugna il diritto naturale della donna al suffragio; e solo si discute intorno alla convenienza e opportunità di applicarlo». Risultato, anche questo progetto si arena.
Nel 1881 nuovo scontro, sulla nuova legge elettorale. Un gruppo di deputati sostiene il suffragio “universalissimo”, e quindi non limitato al censo, cioè solo a chi ha soldi (com’era e sarà ancora per più di trent’anni), ed esteso anche alle donne. Allora è Depretis a opporsi.
 Leggiamo insieme un passo del suo intervento: «Non credo che questa proposta avrebbe il voto favorevole se la stessa più bella metà dell’umana famiglia fosse direttamente consultata (negli atti parlamentari c’è un’annotazione dello stenografo: “Ilarità”). La donna ha altri mezzi d’influenza, di azione assai più potenti del voto! (Altra annotazione nel resoconto: “Ilarità prolungata”)».
Leggiamo insieme un passo del suo intervento: «Non credo che questa proposta avrebbe il voto favorevole se la stessa più bella metà dell’umana famiglia fosse direttamente consultata (negli atti parlamentari c’è un’annotazione dello stenografo: “Ilarità”). La donna ha altri mezzi d’influenza, di azione assai più potenti del voto! (Altra annotazione nel resoconto: “Ilarità prolungata”)».
E quando viene messa ai voti la norma sulle donne, è ovviamente bocciata. E respinto anche un emendamento che introduce il voto femminile ma solo per maestre e laureate.
Stessa sorte tocca alle proposte degli anni successivi e con le più grottesche giustificazioni. Nel 1912, in sede di discussione di una nuova riforma elettorale, Giovanni Giolitti, che pure ha un ruolo fondamentale nell’abolizione del voto per censo e quindi per l’estensione del diritto elettorale a tutti gli uomini, reagisce ad un ennesimo emendamento che estende alle donne il solo elettorato attivo e non anche il diritto di essere elette. «Il voto alle donne – sostiene – equivarrebbe a fare un salto nel buio: qualunque governo sarebbe obbligato a non dar seguito alla riforma». Insomma: «Non si può consentire in un voto che trasformerebbe la vita politica dell’Italia». E, puntualmente, l’emendamento respinto a larghissima maggioranza.
Nel 1924, dopo la presa del potere da parte di Mussolini, sulla carta viene riconosciuto il diritto di voto solo amministrativo alle donne. Il fascismo voleva dimostrare di non aver paura dell’elettorato femminile? Comunque si tratta solo di un trucco demagogico: di lì a poco, e prima che si svolga una qualsiasi elezione per comuni e province, la dittatura abolisce il carattere rappresentativo degli organi locali: è la lunga stagione dei podestà e dei governatori, come pure dei presidi e dei rettori: tutti nominati dal partito fascista. Solo con la Liberazione sulle istituzioni soffierà finalmente il vento della democrazia.
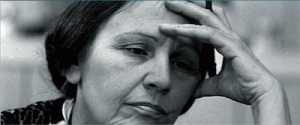 Ho ricordato all’inizio l’incontro tra Nilde Iotti e le suorine. E l’ho fatto non per caso. Iotti non era, non fu mai, una femminista, ma lottò sempre, con un coraggio da tigre, per la parità, per l’emancipazione della donna (non per “la liberazione”, termine che non amava e la distingueva), per la costruzione di una nuova, più moderna immagine della donna. Perché in ballo non c’è stato solo il diritto delle donne di eleggere e di essere elette. Quello fu solo un primo passo. Vediamo qualche passo successivo.
Ho ricordato all’inizio l’incontro tra Nilde Iotti e le suorine. E l’ho fatto non per caso. Iotti non era, non fu mai, una femminista, ma lottò sempre, con un coraggio da tigre, per la parità, per l’emancipazione della donna (non per “la liberazione”, termine che non amava e la distingueva), per la costruzione di una nuova, più moderna immagine della donna. Perché in ballo non c’è stato solo il diritto delle donne di eleggere e di essere elette. Quello fu solo un primo passo. Vediamo qualche passo successivo.
La prima occasione era stata data a Iotti appena qualche mese dopo lo storico 2 giugno ’46. Siamo alla fine del gennaio 1947, lavori della “Commissione dei 75” che preparava la bozza della Costituzione. Si discuteva di un passaggio (poi sparito con un voto dell’Assemblea) dell’art. 106, quello sull’ingresso delle donne in magistratura. Una prima versione prevedeva che «anche le donne« potessero partecipare ai concorsi ma solo «nei casi previsti dalle norme sull’ordinamento giudiziario».
Ce n’era a josa per far sbottare il socialista Ferdinando Targetti, più tardi e a lungo vicepresidente della Camera: «Chiaro, qui ci sono il pensiero e la finalità di limitare l’ammissione delle donne in magistratura. Io invece non vedo alcuna ragione per quella che è una trasparente limitazione dell’accesso delle donne. Di più, non si può da un lato ammettere la presenza, graditissima e utilissima, di tante egregie colleghe nella Costituente, ammettere che la donna possa salire su una cattedra universitaria, e dall’altra negare che la donna abbia le attitudini necessarie per diventare anche consigliere di Cassazione!»
 Ribatté il democristiano Giovanni Leone, poi abile presidente della Camera, infine discusso presidente della Repubblica: «Già l’allargamento del suffragio elettorale alle donne costituisce un primo passo (…) Ma la loro partecipazione illimitata alla funzione giudiziaria non è per ora da ammettersi. Magari sia ammessa al tribunale dei minorenni: sarebbe per esse una ottima collocazione. Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni».
Ribatté il democristiano Giovanni Leone, poi abile presidente della Camera, infine discusso presidente della Repubblica: «Già l’allargamento del suffragio elettorale alle donne costituisce un primo passo (…) Ma la loro partecipazione illimitata alla funzione giudiziaria non è per ora da ammettersi. Magari sia ammessa al tribunale dei minorenni: sarebbe per esse una ottima collocazione. Ma negli alti gradi della magistratura, dove bisogna arrivare alla rarefazione del tecnicismo, è da ritenere che solo gli uomini possano mantenere quell’equilibrio di preparazione che più corrisponde per tradizione a queste funzioni».
Se non che, altre due colleghe di Leone, pur esse democristiane, Maria Federici ed Angela Gotelli (sarà un caso che, come Nilde Iotti era stata staffetta nella Resistenza, così esse fossero state partigiane bianche?), ribatterono, l’una furiosa per quel riferimento alla “tradizione”, e l’altra con un veemente: «Voi volete lasciare indietro le donne!»
Interruzione di altro costituente dc, Giuseppe Codacci Pisanelli: «No, è una questione di resistenza fisica, le donne si stancano di più…». Allora Iotti reagì: «Motivi stupefacenti! Se una donna ha la capacità di arrivarci, e sono convinta che ce l’abbia, essa deve poter conquistare, al pari dell’uomo, i più alti gradi della magistratura, senza alcun discrimine».
E avvertì: «Attenzione: abbiamo appena approvato nella prima parte della Costituzione una norma-chiave: che tutti i cittadini non solo sono uguali ma che tutti, donne e uomini, possono accedere a tutte le cariche pubbliche».
 Il principio del libero accesso delle donne in magistratura sarà infine pienamente accolto dall’Assemblea. Ma, per passare dalla teoria ai fatti trascorsero parecchi anni: solo nel 1963, quindici anni dopo, le donne cominceranno ad entrare effettivamente nei ranghi della magistratura. E nei ranghi della diplomazia: anche qui escluse, e ancora più a lungo, per quasi vent’anni, dalla Farnesina, dai consolati, dalle ambasciate, da qualsiasi rappresentanza diplomatica.
Il principio del libero accesso delle donne in magistratura sarà infine pienamente accolto dall’Assemblea. Ma, per passare dalla teoria ai fatti trascorsero parecchi anni: solo nel 1963, quindici anni dopo, le donne cominceranno ad entrare effettivamente nei ranghi della magistratura. E nei ranghi della diplomazia: anche qui escluse, e ancora più a lungo, per quasi vent’anni, dalla Farnesina, dai consolati, dalle ambasciate, da qualsiasi rappresentanza diplomatica.
Che dire infine della situazione attuale? Della disoccupazione femminile; della condizione della donna costretta a coniugare il lavoro con la famiglia; delle persistenti differenze salariali tra uomo e donna; della pratica impossibilità per la donna di raggiungere i vertici “apicali” nelle imprese pubbliche e private; delle difficoltà tuttora (soprattutto nel Mezzogiorno) di abortire lecitamente nel rispetto della legge 194 per la maledetta “obiezione di coscienza” dell’80% dei medici e infermieri? Ma questa è un’altra storia, dura e spesso drammatica. Chissà che non sia necessario parlarne un’altra volta.




